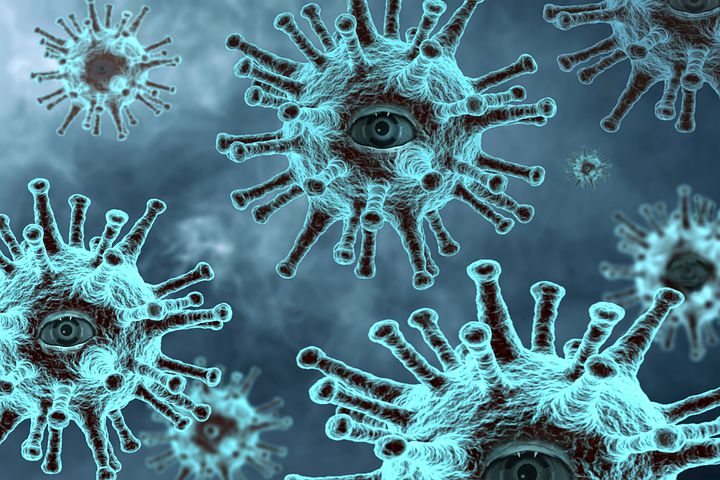Che la “fortuna” giochi un ruolo cruciale nelle nostre vite è innegabile. Ciò detto, che spazio rimane al “libero arbitrio” dell’essere umano? Machiavelli dice che: “[…] affinché il libero arbitrio non sia completamente cancellato, ritengo possa esser vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, e che essa lasci a noi il governo dell’altra metà, o quasi.” (MACHIAVELLI, N., “Il principe”, 1532, Bur Rizzoli, Milano, a cura di Piero Melograni, 1999, p. 217.) Con questo “quasi” non sembrerebbe troppo convinto, pur ammettendo che una buona parte – poco importa se la “metà” precisa – della sua “fortuna” l’uomo se la crea facendo buon uso del “libero arbitrio” di cui dispone. Quindi aggiunge: “E paragono la fortuna a uno di quei fiumi impetuosi che, quando s’infuriano, allagano le pianure, abbattono gli alberi e gli edifici, trascinano masse di terra da una parte all’altra […] Il fatto che i fiumi siano fatti così non impedisce tuttavia agli uomini, nei periodi calmi, di apprestare ripari e argini in modo che, quando i fiumi poi crescono, possano essere incanalati e il loro impeto possa non risultare così sfrenato e dannoso” (pp. 217-219). Costruire “ripari e argini” sempre più contenitivi ed efficienti rimane l’unica cosa da fare all’uomo previdente, che non vuole farsi trovare impreparato dinnanzi al precipitare degli eventi.
È tutta questione di adattarsi o soccombere, secondo Machiavelli, che lo dice con queste parole: “Ritengo inoltre che abbia successo colui che adatta metodi e mezzi alla qualità dei tempi, e analogamente che vada incontro all’insuccesso colui che viceversa non sa adattarsi ai tempi” (p. 219). Adattarsi significa saper assecondare la corrente e non intestardirsi a nuotare controcorrente manco si fosse dei salmoni ostinati. La corrente va assecondata e non combattuta. Se si segue questo accorgimento, si preserva un proprio spazio di manovra per incidere sugli accadimenti, senz’altro limitato, questo sì, è indubbio, ma pur sempre meglio che nessuno spazio. Un’altra metafora può correre in soccorso per capire meglio questo passaggio de “Il principe”. S’immagini di essere un abile marinaio, che sa manovrare con maestria impareggiabile la propria imbarcazione, ma che – nondimeno – è in mare aperto nel bel mezzo di una burrasca. Le chances di cavarsela non dipenderanno soltanto dalla sua pur eccezionale abilità, molta parte – la “metà” o poco più – nella salvezza o meno del marinaio l’avrà l’elemento marino che lo domina e di cui lui è in balia. Cinquanta e cinquanta, nella migliore delle ipotesi: il suddetto marinaio avrà il cinquanta per cento di possibilità di scamparla, però com’è vero che non dipende solo da lui, è pur vero e ragionevole dire che dipende anche da lui.
Bizzarrie della “fortuna”, sentenzia Machiavelli, “[…] magari vediamo che due persone possono aver successo con due modi di comportarsi completamente diversi, dato che per esempio una di queste persone è cauta e l’altra impetuosa. La ragione va trovata nel fatto che esista oppur no un rapporto armonico tra l’operato di queste persone e il carattere dei tempi” (pp. 219-221). Cambiano i tempi e con essi cambiano pure i comportamenti più adatti da tenere. Chi si adegua ha successo, chi no fallisce. Perciò Machiavelli invita a “cambiare coi tempi” per non cambiare in peggio la propria “fortuna” e definisce anche “[…] la variabile del successo: che se uno si comporta con cautela e pazienza nei tempi che esigono queste qualità, allora gli va bene; ma se i tempi cambiano e non cambia anche i suoi comportamenti, allora gli va male” (p. 221). Quindi, a chi recita come un mantra la litania che “andrà tutto bene” per autoconvincersi della buona riuscita di un’impresa, occorre ribadire – sulla scorta dell’insegnamento machiavellico – che “andrà tutto bene” anche se lui lo vorrà e farà in modo con le sue azioni virtuose che così vada. Con la consapevolezza, però, che non dipenderà solo da lui, visto l’influsso della “fortuna” nelle vicende umane. A ogni modo, dovrebbe consolarlo l’idea che per buona parte dipenderà anche da lui (e non è poco).
Per concludere: “[…] se la fortuna è mutevole e gli uomini, viceversa, si ostinano a usare sempre gli stessi metodi, è anche vero che gli uomini hanno successo finché metodi e tempi concordano, e vanno verso l’insuccesso in caso contrario.” Dunque “[…] meglio essere impetuosi piuttosto che cauti, perché la fortuna è donna […]” e per questo motivo, secondo la ristretta e maschilista visione di Machiavelli, figlia di un tempo in cui il maschilismo era ancora più accentuato che nel presente: “Essa si lascia dominare dagli impetuosi, piuttosto che da coloro che si comportano con freddezza. Ecco perché, come donna, essa è amica dei giovani, che sono meno cauti, più impavidi e più audaci nel comandarla” (p. 223). In realtà qui Machiavelli riformula il detto latino riconducibile a uno degli esametri incompiuti di Virgilio secondo il quale: “Audentes fortuna iuvat”. Traduzione: “La fortuna aiuta gli audaci”. Rivisitato nel dannunziano: “Memento audere semper”. Tradotto: “Ricordati di osare sempre”. O il meno raffinato e pure meno fascista (che non guasta), ma di uguale significato: “Chi non risica, non rosica”. Ovvero: chi non rischia, non ottiene nulla. Proverbio toscano come Machiavelli, non a caso.