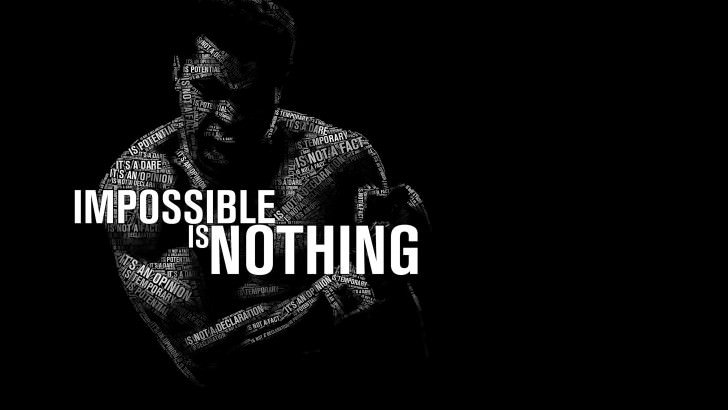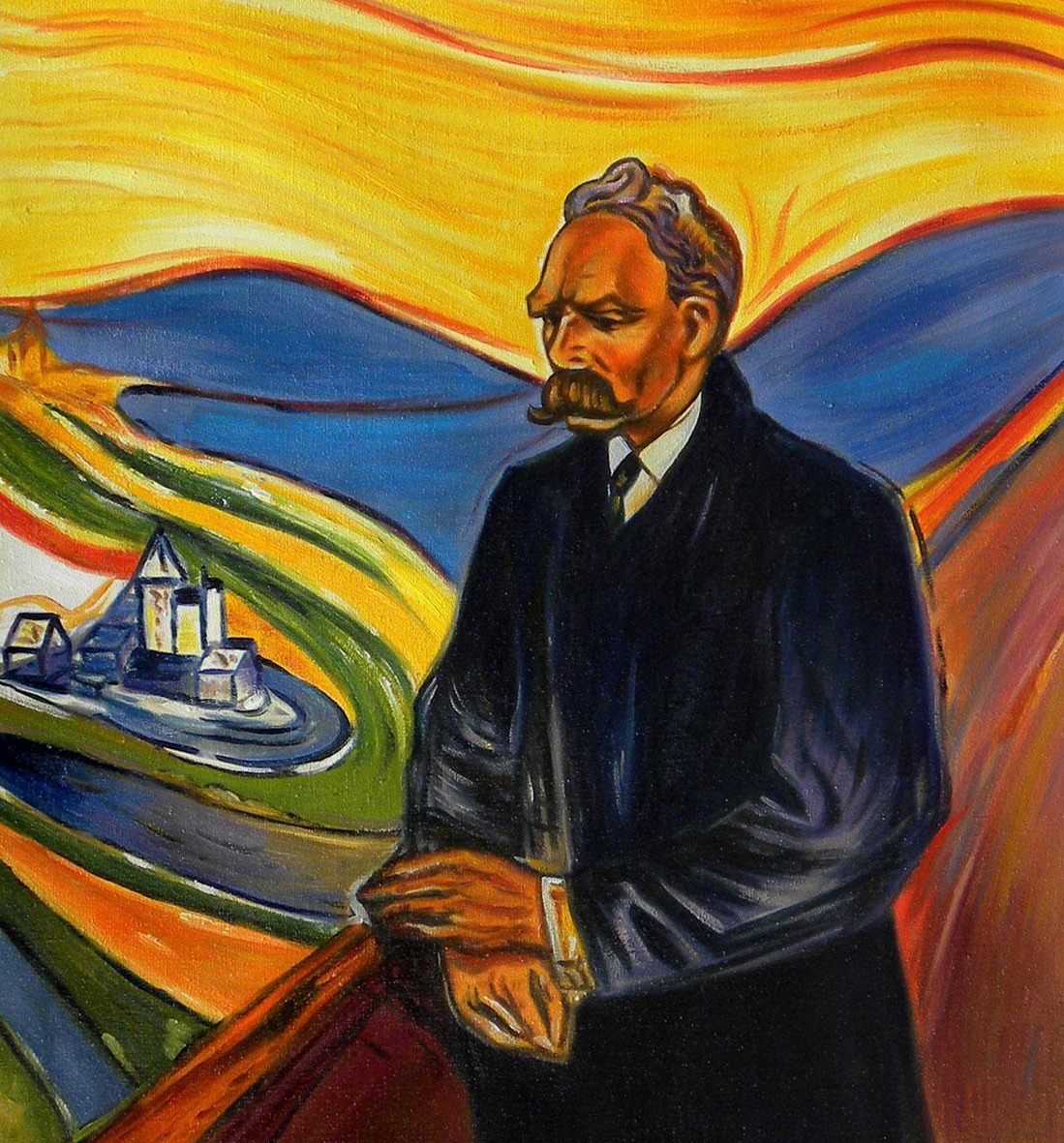Malgrado la componente casualistica, fatalistica o divina dimostrino la precaria e fragile condizione impressa nella filigrana delle nostre esistenze, non possiamo né dobbiamo prescindere dalla componente volontaristica. Altrimenti significherebbe arrendersi senza lottare, quando la lotta è precisamente la condizione necessaria e ineludibile dello stare al mondo. Al contrario, credo che abbiamo bisogno di sviluppare una volontà ponderata, non onnipotente, commisurata al nostro essere creature a cui è dato un certo tempo – per agire e patire, agire è patire – e abitanti un certo spazio.
Volere è davvero potere? Mi è stato obiettato di tenere troppo in conto il detto baconiano “volere è potere”. Rispondo con quella che a me sembra un’ovvietà: se non vuoi, nemmeno puoi. Non è che puoi senza volere. È tecnicamente difficile, per non dire impossibile; anche se i pubblicitari dell’Adidas risponderebbero sulle rime di un loro famoso spot che “impossible is nothing”. Non so voi, ma ripensando alla mia vita, non posso non convenire che quello che ho, ce l’ho proprio perché l’ho fortemente voluto. Per questo do ragione all’affermazione di Francis Bacon, pur non condividendone l’accezione prometeica (da Prometeo, quello che rubò il fuoco sacro agli dèi per favorire il genere umano e inaugurò così l’èra della tecnica). Direi piuttosto d’interpretare – ogni comprensione non può che essere un’interpretazione soggettiva – l’affermazione baconiana più in chiave psicologico-motivazionale. Ergo per me: volere – il più delle volte, non sempre – è davvero potere.
Dalla volontà baconiana il passo per arrivare alla volontà di potenza nietzscheana non è breve, ma neppure troppo lungo. Nel mio libro “Filosofi da Oscar” mi avventuro in una disamina del capolavoro nietzscheano, “Così parlò Zarathustra”, in particolare della sezione dell’opera intitolata “La visione e l’enigma”. Qui espongo quella che è secondo me la peculiarità della volontà di potenza nietzscheana intesa come “affermazione suprema della vita, che rifugge il tanfo sepolcrale di un vissuto passivo, parassitario”; Nietzsche infatti “valorizza la vita, in quanto valore accorpante tutti gli altri” (“Filosofi da Oscar”, pp. 48-49). Cos’altro aggiungere se non che: il segreto della volontà come di tutte le cose è nella misura, nel “giusto mezzo” direbbe Aristotele. Perciò volere è bene, eccedere però ci porta dritti ad Auschwitz, a compiere cioè le più nefande aberrazioni in nome di una volontà onnipotente.
Mi viene in mente l’immagine montaliana della storia; immagine, questa, applicabile anche alla storia individuale, non solo a quella universale; la storia dipinta come una catena di anelli che non sempre tengono. Ciò per dire che qualcosa che ci sovrasta e che ci sfugge c’è e – ho motivo di credere – ci sarà sempre. Che sia il caso, il fato o Dio non importa, poiché si tratta di parole diverse che indicano lo stesso, identico dato di fatto, la precarietà e fragilità dell’essere umano.
Malgrado la componente casualistica, fatalistica o divina dimostrino la precaria e fragile condizione impressa nella filigrana delle nostre esistenze, non possiamo né dobbiamo prescindere dalla componente volontaristica. Altrimenti significherebbe arrendersi senza lottare, quando la lotta è precisamente la condizione necessaria e ineludibile dello stare al mondo. Al contrario, credo che abbiamo bisogno di sviluppare una volontà ponderata, non onnipotente, commisurata al nostro essere creature a cui è dato un certo tempo – per agire e patire, agire è patire – e abitanti un certo spazio.
A proposito della sciagurata volontà di potenza nietzscheana, mi viene da dire che il bello – e anche il più grande limite – di Nietzsche è che ciascuno può fornire una chiave interpretativa differente del suo pensiero. A ogni modo, se la potenza dev’essere sopraffazione della altrui volontà per affermare ed espandere la propria, be’, allora credo sia meglio – nel senso di meno dannoso – un pensatore “impotente”. La volontà di sopraffazione è sempre e comunque becera, lo dico pur essendo un grande estimatore di Nietzsche. Ciò non toglie che pure i grandi possono prendere delle “grandi” cantonate. Comunque, riflettendo su Nietzsche, non si può non tenere presente il delicato rapporto tra pensiero e patologia; a volte, nei suoi scritti, a emergere non è tanto la sua genialità quanto la sua condizione patologica.
Detto questo, come mia abitudine, da ogni filosofo, Nietzsche compreso, cerco di prendere quello che per me è il meglio, mettendo da parte ciò che ritengo non lo sia. La volontà di potenza “non” è quanto di “meglio” può offrire la filosofia nietzscheana. Di Nietzsche preferisco prendermi altro, per esempio: la concezione dell’amare il proprio destino, o “amor fati”.