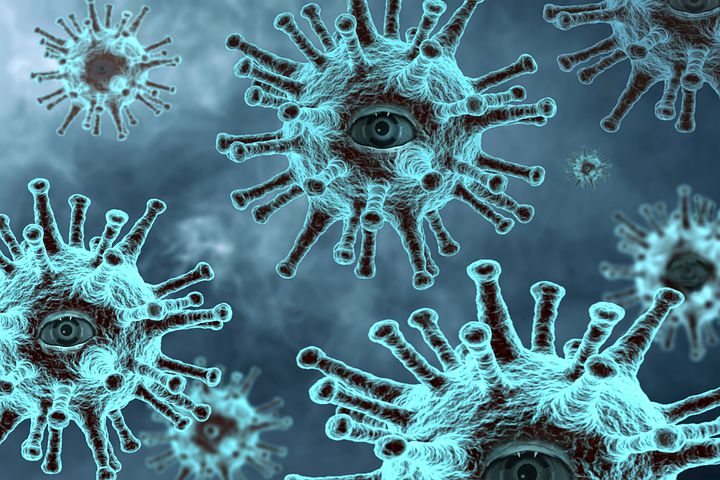Un realista non è né migliore né peggiore di un idealista, è meno visionario ma più necessario, è colui che vorresti avere al comando quando le cose si complicano, perché è in situazioni difficili, di eccezione, che lui dà il meglio di sé; è il miglior compagno con cui si possa dividere la trincea, però è il peggiore con cui condividere una bevuta. In una situazione di normalità il realista consiglia di prepararti al peggio, mentre tutti gozzovigliano e pensano a godersi il meglio credendo che a esso non potrà esserci fine; mentre l’uomo saggio, che è realista, sa che solo “al peggio” non c’è limite, per questo si tiene pronto a vendere cara la pelle.
Il principe, così come lo intende Machiavelli, dovrebbe essere dotato di un sano pragmatismo, che lo porti a valutare il mondo e gli uomini per quello che “sono” e non per quello che “dovrebbero essere”. Ciò presuppone una visione realista più che pessimista sia del mondo sia degli uomini che lo abitano. Perché “realista” e non “pessimista”? Il pessimista si bea della propria arguzia intellettuale e non è interessato a risolvere problemi. Il realista non si compiace delle sue idee ed è soltanto focalizzato a risolvere problemi. L’uno ha l’animo del letterato disilluso che porta su di sé il peso del mondo, novello Atlante. L’altro ha una chiara ed evidente vocazione politica, di chi marxianamente non si accontenta di capire il mondo e ha tutta l’intenzione di trasformarlo (si veda l’undicesima “Tesi su Feuerbach” di Karl Marx). Per effettuare questa trasformazione un realista sa bene di doversi sporcare le mani, perché le faccende mondane non si sbrigano rimanendo sul piano ideale che, tutt’al più, deve fungere da trampolino di lancio perché il suo scopo è incidere sulla realtà.
Un realista non è né migliore né peggiore di un idealista, è meno visionario ma più necessario, è colui che vorresti avere al comando quando le cose si complicano, perché è in situazioni difficili, di eccezione, che lui dà il meglio di sé; è il miglior compagno con cui si possa dividere la trincea, però è il peggiore con cui condividere una bevuta. In una situazione di normalità il realista consiglia di prepararti al peggio, mentre tutti gozzovigliano e pensano a godersi il meglio credendo che a esso non potrà esserci fine; mentre l’uomo saggio, che è realista, sa che solo “al peggio” non c’è limite, per questo si tiene pronto a vendere cara la pelle. Il realista non piange lacrime di coccodrillo “a posteriori”, interviene “prima” per non avere dei rimorsi “dopo”, anche se ciò significa non avere scrupoli di coscienza; avere una coscienza è un lusso che non può permettersi. Il realista è bravo a decidere e non si arrovella – inconcludente – nel dubbio, non è un fannullone, è un uomo d’azione, è un interventista e questo è il suo più grande pregio ma anche difetto.
Machiavelli non usa queste parole, però il senso del suo discorso non è tradito da questa interpretazione, che alla fine si riconduce a questo motto capovolto: non ti devi fasciare la testa prima di spaccartela, questo no, piuttosto devi metterti l’elmetto così da prevenire qualche brutto incidente. Prevenzione, è questa la parola d’ordine. Previeni per attenuare il più possibile i rovesci della dea Fortuna, che sarà pure bendata, però prende di mira tutti. La preveggenza è un palliativo che attenua il problema ma non lo risolve e se non lo fa è perché non può.
Il problema dell’uomo, l’unico, vero che ha, la morte, è irrisolvibile. Se si vuole provare a ritardarla più che si può – non è detto che si riesca seppure “il gioco vale la candela” – occorre immaginare il lupo dietro ogni angolo, pronto ad azzannarci alla gola in ogni momento, a mordere la giugulare e recidere con essa la nostra vita. “Attenti al lupo” non è solo una splendida canzone di Lucio Dalla, è un modo di vivere in perfetto “Machiavelli style”, che verrà dopo di lui riproposto da un altro filosofo realista, con il quale c’è da scommetterci che Machiavelli avrebbe volentieri diviso la tavola, questi è Thomas Hobbes. Per denunciare l’alto grado di pericolosità dello stato di natura, Hobbes è ricorso alla celebre formula “homo homini lupus”, l’uomo è lupo per l’altro uomo.
Il lupo come metafora del nemico è solo un modo di vedere – per quello che è – la condizione umana, mortale; non lo fosse stata, i discorsi starebbero a zero, perché vorrebbe dire che l’uomo non sarebbe più quel che è e, di conseguenza, non avrebbe più bisogno di “risolvere problemi”. Finché dovrà impantanarsi in essi e provare a venirne a capo, fino ad allora “Il principe” di Machiavelli non potrà che essere visto come un prezioso compagno di cammino per l’uomo, usato vuoi per tracciare la rotta e vuoi anche per non smarrire la via dell’agire politico.
C’è un passo de “Il principe” in cui riecheggiano forti e chiare le parole di Machiavelli, un passo che lo ingloba nella squadra degli aristotelici “realisti”, mentre la squadra avversaria è quella dei platonici “idealisti”. Il passo è questo: “Molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti nel mondo reale. Ma c’è una tale differenza tra come si vive e come si dovrebbe vivere, che colui il quale trascura ciò che al mondo si fa, per occuparsi invece di quel che si dovrebbe fare, apprende l’arte di andare in rovina, più che quella di salvarsi. È inevitabile che un uomo, il quale voglia sempre comportarsi da persona buona in mezzo a tanti che buoni non sono, finisca per rovinarsi. Ed è pertanto necessario che un principe, per restare al potere, impari a poter essere non buono, e a seguire o non seguire questa regola, secondo le necessità” (MACHIAVELLI, N., “Il principe”, 1532, Bur Rizzoli, Milano, a cura di Piero Melograni, 1999, p. 151).
Aristotele si potrebbe considerare il capostipite di una filosofia realista di cui Machiavelli è degno erede. Aristotele è stato il primo a smontare l’idealismo di Platone. Come? Gli è bastato puntare il palmo della mano verso il basso, verso il mondo terreno (delle copie secondo la vulgata platonica) al contrario del suo maestro ostinato a tenere il dito indice puntato verso l’alto, verso il mondo ultraterreno (delle idee stando sempre alla terminologia platonica). L’immagine dei due filosofi ritratti nelle pose sopra descritte ce l’ha regalata Raffaello Sanzio nel dipinto “La scuola di Atene”.
Se Platone invita a guardare a “ciò che dovrebbe essere”, Aristotele suggerisce di considerare “ciò che è”. Hanno entrambi in parte torto e in parte ragione. Ha ragione Platone a chiedere all’uomo uno sforzo aggiuntivo per non accontentarsi delle cose come sono e per provare a cambiarle in meglio inseguendo un ideale che serve per migliorare il reale. Ha ragione però anche Aristotele che per venire a capo dei problemi non si può prescindere da com’è fatto l’uomo e da come funziona il mondo. La politica è ciò che sta nel mezzo tra ideale e reale. Il politico deve avere un ideale per incidere sul reale, però deve essere disposto a usare i mezzi che il proprio ingegno gli suggerisce per raggiungere il fine che si prefigge.
43.306109
13.720006