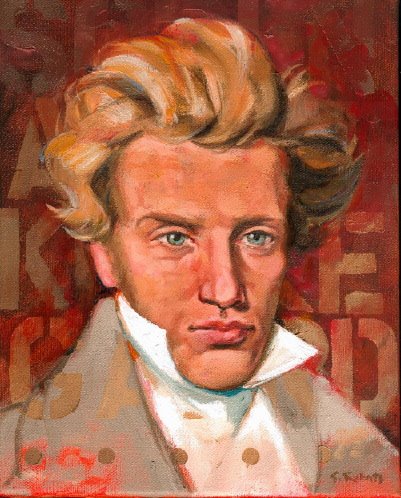Un certo pessimismo è sano, perché ci tiene con i piedi ben piantati per terra, ci cura dalla sindrome del Padreterno che ce n’è uno – almeno per me – e non milioni di milioni. Trovo interessante il modo di concepire la storia proprio di Tolstoj, il quale, romanzando la figura del generale russo Kutuzov (fautore dell’annientamento progressivo dell’esercito napoleonico grazie a una tattica attendista), veicola l’idea che l’atteggiamento proprio di chi fa la storia è fatalistico. Il punto è questo: siccome non siamo noi a dominare gli eventi, piuttosto è il contrario, tanto vale lasciare andare le cose così come il fato, il caso o Dio vuole che vadano.
I romantici credono nel fato, gli scienziati nel caso, i mistici in Dio. Poco importa come lo si chiama, sempre a un concetto superiore e travalicante l’umana piccolezza si fa riferimento. Nietzsche – che, per quanto critica il Romanticismo, si può considerare un romantico, seppure “sui generis” – usa il termine “amor fati” per descrivere il suo fatalismo. Con la loro hit “Let it be”, i Beatles dicono più o meno la stessa cosa.
È pessimistico questo modo di vedere le cose? Forse, o forse è soltanto realistico. A dirla tutta, mi definirei più un realista che un pessimista, che poi: dire che l’uomo è soverchiato da forze più grandi di lui ed è libero solo entro certi limiti è un po’ come riscoprire l’acqua calda. Tuttavia, a volte, un po’ di sana “acqua calda” fa bene all’anima. Concepito in questi termini, allora sì che il pessimismo, o realismo che dir si voglia, può essere salutare per l’uomo.
Prendo a esempio il caso emblematico delle guerre. Gli idealisti, in malafede o ingenui (spero più la seconda), credono nella “pace perpetua” di kantiana memoria. Dunque, sono fiduciosi che altre carneficine mondiali non verranno compiute, perché si sa – dopo Hiroshima e Nagasaki – finalmente gli esseri umani hanno capito la lezione e non commetteranno più gli stessi sbagli. La politica di deterrenza nucleare dà e continuerà a dare i suoi frutti pacifici. Certo, come no, credeteci pure, pensano i realisti. In fondo un realista dice semplicemente le cose come stanno e in materia di conflitti: la guerra è la regola, la pace è l’eccezione. “La pace è l’intervallo tra due guerre”, per dirlo con il celebre aforisma di Jean Giraudoux; intervallo che può essere più o meno lungo. Basta aprire qualsiasi manuale di storia per capire chi ha ragione, se gli idealisti o i realisti. Come diceva mio nonno: “La ragione si dà ai fessi”. Da realista, in questo caso, non ci tengo ad avere ragione, anzi. Spero con tutto me stesso che non si combatteranno più guerre cosiddette “mondiali” (quelle “locali” non si sono mai interrotte), ma a un livello più razionale non mi stupirei se dovessimo ricadere nel medesimo errore. E una cosa è certa, tra idealisti e realisti, i secondi – più pragmatici – hanno fatto molto più dei primi e delle loro belle parole per assicurare una pace duratura. Da qui però a darla per scontata ce ne vuole e sarebbe un errore imperdonabile, oltretutto dalle conseguenze catastrofiche.
La storia è “magistra vitae”, diceva Cicerone. A mio avviso, a vedere la cocciutaggine degli uomini, la storia non è maestra di niente; eppure dagli errori passati si dovrebbe trarre un qualche insegnamento. Parafrasando Einstein: non so se verrà mai combattuta una terza guerra mondiale, ma se dovesse capitare so per certo con quali armi verrebbe combattuta la quarta, con le clave di pietra. Prima ho detto che sono tra quelli che ritengono sacra e inviolabile la vita umana, ma ci tengo a precisare che questo principio morale – non saprei come altro definirlo – non si applica a coloro che non ritengono sacra e inviolabile la vita altrui. C’è un detto latino che dice: “Vuoi la pace, preparati alla guerra”. Lo condivido in pieno. Con chi vuole il mio annientamento non credo di avere la forza morale di un Gandhi. La non violenza è tanto bella quanto inapplicabile per me. Se tu mi attacchi io ti rispondo: “Mors tua vita mea”. E a pensarla così sono in buona compagnia, persino lo Stato del Vaticano è per l’autodifesa, se attaccato.